Una realtà riproposta dalla serie televisiva "I sopravvissuti". COME VIVERE DOPO LA FINE DEL MONDO.
Il futurologo Roberto Vacca, autore di "Medioevo prossimo venturo" ci spiega cosa potrebbe succedere in una società sconvolta da catastrofi epidemiche o nucleari. Dopo un periodo di "abbondanza" verrebbe a mancare qualsiasi risorsa.
Era una meravigliosa statua di marmo pario scolpita molti
secoli prima da un grande maestro greco. I due omaccioni non la
degnarono di uno sguardo. La fecero a pezzi a mazzate e usarono i
frammenti per murarli in una parete abbastanza storta della casa -
piccola e brutta - che stavano costruendo. Poi, la sera mangiarono solo
formaggio di capra - e le capre le tenevano in stalle arrangiate nei
palazzi imperiali. Le mangiatoie delle bestie erano vasche preziose di
porfido imperiale. Questo succedeva a Roma 900 anni fa. La popolazione
dell'Urbe era soltanto di 30.000 abitanti - contro i due milioni del
periodo imperiale di massima fioritura. Non sappiamo neanche bene
perchè I'impero romano è decaduto diventando impotente e
spopolato. Diciamo che è successo per disorganizzazione, per
mancanza di civismo e di produttività, per gli attacchi dei
barbari o per la mancanza di altri Paesi da depredare. Sappiamo solo
che il Medioevo che seguì è stata un'epoca dura e
violenta, in cui pochissimi godevano di lussi modesti e la maggioranza
viveva nella miseria, nell'ignoranza e nella fatica. Nello sceneggiato
televisivo "I sopravvissuti" è stato rappresentato un ritorno
del Medioevo con una diminuzione della popolazione dell'Inghilterra da
60 milioni a poche centinaia di migliaia di persone. La causa di questi
milioni di morti, nello sceneggiato, è una pestilenza. Sono
anticipazioni tragiche e serie e dobbiamo considerarle con
serietà. Esiste veramente il pericolo di una pestilenza che
uccida il 99% della popolazione? Molto probabilmente no. L'Europa
è stata già attaccata dalla peste bubbonica - la morte
nera - nel XIV secolo. La pestilenza bloccò ogni sviluppo civile
per qualche decennio, ma non distrusse la società - uccise meno
di metà della popolazione europea. Quali sono i veri rischi che
corre la nostra società, allora? Leggendo i giornali sembra che
uno dei rischi più temuti sia quello connesso allo sviIuppo
dell'energia nucleare. Parecchi movimenti cercano di bloccare la
costruzione delle centrali elettronucleari. Parecchi giornalisti
scrivono articoli catastrofici sull'incidente della centrale nucleare
di Harrisburg in Pennsylvania, in cui, dopo tutto, i sistemi di
sicurezza hanno funzionato abbastanza bene. Hanno perfino chiamato
"bolla H" una certa quantità di idrogeno sviluppatasi nel
reattore, quasi per richiamare il nome della bomba H. Invece l'idrogeno
di Harrisburg potrà tutt'al più scoppiare combinandosi
con l'ossigeno - mentre l'idrogeno della bomba H si fonde col trizio
formando elio e producendo una energia enorme: cioè, nella
bomba, una potenza distruttiva pari a quella di milioni di tonnellate
di tritolo. Le bombe atomiche e le bombe H sono un pericolo vero: al
mondo ce ne sono alcune decine di migliaia. Sono sufficienti a
ucciderci tutti: non una volta sola, ma molte, molte volte. Non
è probabile, però, che le armi nucleari siano lanciate in
modo così accurato e malvagio da uccidere tutta la popolazione
mondiale. E' concepibile, quindi, che muoiano 99 persone su 100 e che
restino solo pochi sopravvissuti. E' un'ipotesi semplice e tragica. Ma
non è la sola. Un altro rischio grave è quello della
complicazione eccessiva nei Paesi avanzati. Gli esperti - urbanisti,
sistemisti - non sanno se le dimensioni massime di una città
possano essere fissate a 20, 30 o 40 milioni di abitanti. Però
oltre questo limite sconosciuto e verso cui stiamo andando, può
succedere che la città muoia di disorganizzazione, perchè
non funziona più niente. Abbiamo già avuto esperienza dei
black out elettrici. Se un black out più grave si accoppia a uno
sciopero, a un'epidemia o a una ondata di gelo, potrebbe succedere che
milioni di persone restino intrappolate nelle metropoli senza
approvvigionamenti, senza potersi muovere, nè scaldare, e senza
poter nemmeno comunicare. Esistono, perciò, dei pericoli veri al
verificarsi dei quali sopravviveremmo in pochi. Lo scheletro della
società che resterebbe, dopo una catastrofe così grossa,
sarebbe veramente medioevale: senza comunicazioni, senza industria,
senza servizi, senza cure efficienti e senza tempo da dedicare alla
cultura, all'apprendimento, alla scienza. La somiglianza con il
Medioevo passato - quello di mille anni fa - non si limiterebbe solo
alle condizioni di povertà e di vita dura. La brusca diminuzione
di popolazione avrebbe per conseguenza anche un blocco quasi totale
delle innovazioni e della stessa industria. Perchè? Ho
già raccontato come i muratori medioevali trovassero in giro
tante statue e pietre già squadrate, provenienti dal periodo
precedente in cui c'era più gente. In un avvenire tragico, come
quello che immaginiamo, i pochi sopravvissuti troverebbero: macchine,
cibi conservati, medicine, vestiario, abitazioni, carburante in
quantità talmente superiori ai loro bisogni da bastare per un
secolo. Durante quei cento anni non servirebbe proprio produrre altri
beni, altri oggetti o studiare come ricostituire l'industria. Non
servirebbe, cioè, a breve termine. A lungo termine, invece, dopo
che le tecniche di oggi sono state dimenticate, i figli dei
sopravvissuti verrebbero su come barbari nell'ambiente complicato e in
via di sfacelo lasciato dalla civiltà tecnologica attuale.
C'è da sperare che questi disastri non si verifichino mai.
Perchè ne parliamo, allora? Che interesse può avere la
storia di eventuali sopravvissuti che, forse, non si troveranno mai in
una situazione catastrofica come quelle di cui ho parlato? Un primo
interesse è quello della finzione artistica. I drammi devono ben
essere basati su situazioni veramente drammatiche. Immaginare queste
catastrofi possibili in modo vivido può servire anche a renderci
conto di quanto terribili potrebbero essere veramente. Una volta
convinti di questo, dovremmo lavorare più intensamente per
rendere sempre più improbabili queste sciagure. Dovremmo darci
da fare per il disarmo nucleare e svegliare l'opinione pubblica, che
alle bombe atomiche non pensa più affatto. Dovremmo contribuire
a far crescere l'efficienza, la stabilità, la razionalità
della nostra società. La distruzione dei sistemi attuali - che
avvenga casualmente o per ragioni belliche, come abbiamo supposto, o
che venga raggiunta con premeditazione da movimenti eversivi - non
porterebbe a una società giusta, buona e utopica, ma porterebbe
- e solo per pochi - a un'era fosca, dura e ingiusta.
Roberto Vacca
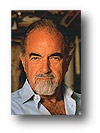
Roberto Vacca, laureato in Ingegneria Elettrotecnica, è docente all' Università di Roma e a quella di Milano e ha partecipato a vari programmi televisivi di divulgazione scientifica. Tra i suoi libri citiamo: IL MEDIOEVO PROSSIMO VENTURO (1971) e LA MORTE DI MEGALOPOLI (1974), ora disponibili online in formato pdf anche in inglese.

Venerdì 30 marzo in Pennsylvania, nella centrale nucleare di Harrisburg, è accaduto il "fattaccio" che ha messo in allarme almeno un milione di persone. Un incidente al sistema di raffreddamento di un reattore atomico ha prodotto emissioni di gas radioattivo (Xenon 133) nell'atmosfera esterna. Per fortuna, la fuga di gas era di bassa densità radioattiva. La paura però si è ulteriormente diffusa perchè all'interno del reattore si era formata una bolla di idrogeno che ne ha impedito per alcuni giorni il raffreddamento. La mappa (qui a fianco) delle centrali degli stabilimenti nucleari in Italia potrebbe suscitare altre paure. In effetti, una centrale nucleare non può scoppiare come una bomba atomica. Anche nel caso di fuoriuscita di molto gas, non si formerebbe "il fungo atomico": quindi non c'è il pericolo di cui molti parlano.
Jane Fonda, donna e attrice impegnata (qualche volta arrabbiata) si trova al centro di una nuova polemica dopo l'uscita del suo film "The China syndrome", una storia sui pericoli dell'energia nucleare. Il film, prodotto da Michael Douglas, figlio di Kirk (il produttore di "Qualcuno volò sul nido del cuculo"), denuncia le possibili disastrose conseguenze provocate da un incidente in un centro nucleare californiano. Jane Fonda è la telecronista che dovrebbe commentare l'accaduto per un'importante stazione televisiva: ma i dirigenti dell'emittente si rifiutano senza mezzi termini di dare la notizia. Jane riprende le immagini insieme al cineoperatore (Mlchael Douglas), documenta le terribili scene di panico e assiste all'azione omicida dei capi esecutivi del centro nucleare, pronti a far tacere il capotecnico (Jack Lemmon) che s'era lasciato andare ad alcune dichiarazioni compromettenti. Il film (un grosso successo di questi giorni in America) ha già avuto parecchie clamorose ripercussioni. La General Electric, una compagnia del genere di quella denunciata sullo schermo, ha sabotato proprio un'intervista televisiva con Jane Fonda. "The China syndrome" non solamente affronta il problema nucleare (precedendo a grandi linee con la fantasia quello che in questi giorni è accaduto in America nella centrale di Harrisburg) ma scaglia anche una pietra contro le grosse concentrazioni televisive. Jane Fonda, in attesa degli sviluppi delle polemiche (che probabilmente aumenteranno con l'arrivo di "The China syndrome" in Europa: sarà presentato al festival di Cannes), sta girando un nuovo film accanto a Robert Redford.